Tra il 1796 e il 1815 l’Italia subì una delle più grandi perdite del suo patrimonio artistico. Le armate di Napoleone Bonaparte, durante le campagne militari, portarono in Francia centinaia di opere d’arte, libri, gioielli e tesori di ogni genere. Molti di questi capolavori finirono al Louvre o in altri musei francesi, alcuni furono restituiti dopo la caduta dell’Impero, altri sono tuttora all’estero, altri ancora andarono perduti per sempre.
Lo storico Yann Potin ha scritto che queste spoliazioni cambiarono per sempre la geografia culturale d’Europa: non si trattò solo di “furti”, ma di un’operazione che ridisegnò il destino delle collezioni artistiche di interi Paesi.
Cosa fu portato via
I francesi non si limitarono ai quadri e alle sculture: requisirono anche manoscritti, strumenti scientifici, medaglie, tessuti, arredi sacri, oro e argento. Molti di questi beni provenivano da chiese e monasteri che, a causa delle soppressioni napoleoniche, venivano chiusi e secolarizzati.
Inizialmente era Napoleone stesso a indicare cosa prendere. Poi vennero creati dei veri e propri “commissari d’arte”, scienziati e artisti incaricati di seguire l’esercito e scegliere le opere più importanti da inviare a Parigi. A volte il lavoro fu meticoloso, altre volte rozzo e violento, con opere danneggiate durante il trasporto.

Le principali requisizioni in Italia
Le spoliazioni seguirono l’avanzata militare francese.
- Regno di Sardegna (1796): con l’armistizio di Cherasco il re fu costretto a consegnare 100 opere, tra cui l’Annunciazione di Rogier van der Weyden, oggi divisa tra il Louvre e la Galleria Sabauda.
- Lombardia: dalla Biblioteca Ambrosiana fu portato il Codice Atlantico di Leonardo, mentre chiese e conventi persero capolavori come l’Incoronazione di spine di Tiziano e la Madonna della Vittoria di Andrea Mantegna (oggi al Louvre).
- Emilia: a Bologna furono prelevati capolavori come l’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello e la Strage degli innocenti di Guido Reni, poi restituiti dopo il 1815.
- Stato della Chiesa: con il Trattato di Tolentino (1797) Roma dovette consegnare tesori antichi e moderni, tra cui il Laocoonte, l’Apollo del Belvedere, la Trasfigurazione di Raffaello e molte altre opere. Gran parte rientrò grazie all’intervento di Antonio Canova dopo la Restaurazione.
- Venezia: subì forse la perdita più dolorosa. I francesi portarono via i celebri Cavalli di San Marco, il tesoro della basilica e dipinti come le Nozze di Cana di Veronese (oggi al Louvre).
Anche Toscana, Liguria, Napoli e Parma furono più volte saccheggiate, specialmente negli anni tra il 1799 e il 1813.

Le giustificazioni giuridiche
I prelievi non venivano presentati come furti, ma come clausole dei trattati di pace. Ogni armistizio prevedeva, oltre a soldi e territori, anche la consegna di opere d’arte. Per esempio, l’armistizio di Bologna del 1796 obbligava il papa a cedere 100 opere tra statue, dipinti e manoscritti.
Questa pratica era del tutto nuova: Napoleone stesso ammise che inserire opere d’arte nei trattati poteva sembrare “bizzarro”, ma presto divenne una consuetudine. Nonostante ciò, dopo la caduta dell’Impero, molti Stati riuscirono a contestare legalmente la validità di quelle clausole e a ottenere la restituzione di parte dei beni.
Le motivazioni culturali
Oltre al diritto di guerra, i francesi avevano una giustificazione ideologica: l’idea che Parigi dovesse diventare la “capitale mondiale delle arti”, una sorta di nuova Atene. Le opere d’arte dei popoli conquistati venivano considerate “liberate” dall’ignoranza e portate nel Museo Universale di Parigi (il futuro Louvre) per essere messe al servizio dell’umanità.
Secondo i rivoluzionari, l’arte non era più un lusso per pochi o un oggetto legato al culto religioso, ma uno strumento per l’educazione e il progresso. Così il museo divenne un luogo pubblico con una missione sociale: formare i cittadini e diffondere i valori universali.

Le critiche e le conseguenze
Non tutti in Francia erano d’accordo. L’intellettuale Quatremère de Quincy denunciò il danno che le spoliazioni provocavano: togliere le opere dal loro contesto significava privare i popoli di punti di riferimento culturali e ridurre la possibilità di comprenderle appieno. Inoltre, egli sosteneva che un grande museo centralizzato non poteva sostituire i legami tra opere, città e tradizione locale.
Alla fine, però, il modello vincente fu quello del museo universale, che ispirò anche altri Paesi europei nell’Ottocento. Paradossalmente, i saccheggi francesi contribuirono a far nascere nei popoli occupati un nuovo sentimento: la coscienza di avere un patrimonio artistico nazionale da difendere e valorizzare.
Il ruolo di Antonio Canova e il ritorno delle opere
Dopo la caduta di Napoleone nel 1815, l’Italia iniziò la difficile opera di recupero dei capolavori trafugati. A guidare questo processo fu Antonio Canova, uno dei più grandi scultori del tempo, nominato primo soprintendente delle arti italiane dal papa Pio VII. Canova si recò personalmente a Parigi, negoziando con le autorità francesi e seguendo la restituzione delle opere più importanti. Grazie al suo impegno tornarono in Italia dipinti, sculture e manoscritti, come l’Estasi di Santa Cecilia di Raffaello o la Strage degli Innocenti di Guido Reni.
Il lavoro di Canova non fu solo un recupero materiale, ma anche un atto simbolico: dimostrò quanto fosse importante per un popolo avere accesso alla propria arte e cultura, rafforzando l’idea di patrimonio nazionale e l’attaccamento alla propria storia.
La storia delle spoliazioni napoleoniche ci ricorda che l’arte non è solo bellezza, ma anche memoria storica e identità culturale. Ancora oggi molti Paesi discutono su opere d’arte spostate o trafugate nel passato: chi dovrebbe possederle? Dove è meglio conservarle? È interessante osservare come i musei moderni nascono proprio da questa storia: oggi l’arte è accessibile a tutti, ma il dibattito sul contesto e la provenienza continua a essere centrale.
Una bufala che continua a correre
Nonostante la Gioconda sia in Francia dal 1518, molti ancora credono che Napoleone l’abbia rubata. Questa leggenda metropolitana è così radicata che persino Vincenzo Peruggia, l’autore del celebre furto del 1911, ne era convinto. Per lui, restituire il dipinto all’Italia era un atto patriottico. Peccato che la Gioconda fosse già di proprietà francese da secoli!

Approfondimenti e risorse consigliate
Se vuoi scoprire di più sulle spoliazioni napoleoniche e sull’arte italiana del periodo, ecco alcune risorse interessanti.
Video riassunto: I Furti napoleonici in Italia.
Vittorio Sgarbi spiega il Louvre di Napoleone.
Mappa concettuale su Napoleone Bonaparte.
Kahoot: Quanto ne sai su Napoleone?
Valter Curzi, Il Museo Universale. Da Napoleone a Canova, Skira Editore, 2017.
Paul Wescher, I furti d’arte. Napoleone e la nascita del Louvre, Yes Gestae, 2022.
Jeremy Irons, Napoleone: nel nome dell’arte (DOCUMENTARIO – disponibile nella versione integrale su YouTube e su Amazon Prime).
Ridley Scott, Napoleon, 2024 – Film biografico
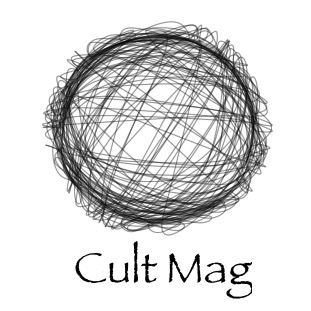












Leave A Reply